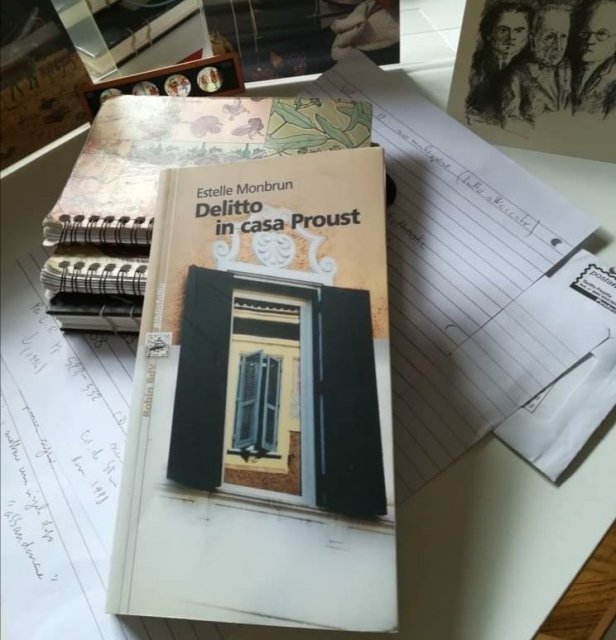
di Mariolina Bertini
L’ambiente particolarissimo in cui si situa questo classico giallo “all’inglese” è indicato con precisione dal titolo originale: Meurtre chez Tante Léonie, Delitto a casa della zia Léonie. La cosiddetta “casa della zia Léonie” è il tempio per eccellenza di quei lettori di Proust che vivono l’ammirazione per l’autore della Recherche come una sorta di culto. Si trova a Illiers, ribattezzata nella Ricerca Combray: il piccolo centro vicino a Chartres lungamente descritto nella prima parte de La strada di Swann.
A Illiers, luogo d’origine della sua famiglia paterna, Proust passò in effetti le vacanze sino ai tredici anni, quando per la sua asma divenne troppo irritante il contatto con la ricca vegetazione della campagna; è facile riconoscere nelle sue pagine le rive del fiume Loir e le collinette fiorite di biancospini che a primavera racchiudono quel piccolo centro in una cornice di incantevole freschezza. Più problematico muovere alla ricerca degli scenari di vita familiare evocati nel romanzo. Ne La strada di Swann la casa e il giardino della zia Léonie, malata immaginaria che dalla finestra spia attentamente gli andirivieni dei compaesani, sono il risultato di una sorta di contaminazione tra i ricordi di una villa di Auteuil, che apparteneva alla famiglia della madre di Proust, e i ricordi di Illiers, dove i Proust erano effettivamente ospiti di una zia, Élisabeth Amiot, un po’ simile nel carattere e nelle abitudini alla zia Léonie della Ricerca. Man mano però che Proust entrava tra i classici indiscussi della modernità, compiendo nel canone un’ascesa lenta ma sicura, la volontà dei notabili di Illiers di farne una gloria locale si faceva sempre più evidente e imperiosa. Nel 1954, la villetta di Élisabeth Amiot, ribattezzata “casa di zia Léonie” e stipata di arredi d’epoca di dubbia autenticità, è stata trasformata in un piccolo museo. Nel 1971, poi, proprio mentre si celebravano i cent’anni dalla nascita di Proust, Illiers è diventata ufficialmente Illiers-Combray sulle mappe e sui cartelli stradali, sovrapponendo alla propria identità geografica un’identità letteraria orgogliosamente rivendicata.
Negli anni Cinquanta l’autore della più fortunata biografia di Proust, George Painter, bibliotecario del British Museum, poteva avere ancora l’illusione di immergersi, per le sue ricerche, nella cittadina quale l’aveva conosciuta il romanziere:
Ai nostri tempi – scrive durante la stesura della sua opera – venerdì è sempre giorno di mercato; il selciato si copre di paglia, cavolfiori, stivali chiodati, ferramenta, tappeti, e tutti gli abitanti di Illiers si danno convegno sulla piazza, per vendere o per comprare. Quando passa un estraneo, tutti interrompono ciò che stanno facendo e lo guardano con stupita ostilità, con un sentimento simile a quello della zia Léonie quando vedeva dalla finestra “un cane che non conosceva”.
Ma a partire dal 1959, proprio il successo internazionale del libro di Painter, con le sue dettagliatissime descrizioni di Illiers e dintorni, contribuì probabilmente a cambiare la situazione; è da allora che la cittadina attira ogni anno una folla crescente di turisti, per cui la casa della zia Léonie ha lo stesso fascino del trenino dei sette nani a Disneyland o della piccola Venezia di Las Vegas.
Nel romanzo di Estelle Monbrun (Delitto in casa Proust, ed. orig. 1994, traduzione di Emilia Gut, Roma, Robin, 2003, pp. 215, € 11), i visitatori anonimi – quelli che fotografano devotamente la presunta teiera della zia Léonie sgranocchiando madeleines – restano sullo sfondo, come un mero elemento di colore locale; al centro del racconto ci sono i proustiens, gli specialisti dello scrittore, ritratti, agli inizi degli anni Novanta, in un momento privilegiato della fortuna della sua opera. È un momento che potremmo definire euforico, carico di promesse e di emozioni. Tra il 1987 e il 1989 è stata pubblicata, nella più elegante collezione di Gallimard, la Bibliothèque de la Pléiade, una nuova edizione della Recherche, messa a punto da una straordinaria équipe di studiosi capeggiati da Jean-Yves Tadié. In questa edizione, in cui ciascun romanzo è seguito da un’ampia scelta di abbozzi, ogni lettore ha accesso ai segreti della genesi dell’opera: se molti, negli anni Venti, avevano creduto che Proust gettasse sulla carta i propri ricordi “senza nulla scegliere e nulla sacrificare”, ora lo strenuo lavoro di costruzione e di instancabile rielaborazione che sta alla base della Ricerca è sotto gli occhi di tutti. E dai ricchi apparati della nuova edizione affiora un altro romanzo, di cui sono protagonisti i manoscritti dello scrittore: i 75 quaderni conservati, dal 1962, alla Bibliothèque Nationale di Parigi, documentano soltanto in parte la lunga genesi dell’opera. Quanti altri quaderni sono stati bruciati, per ordine di Proust, dalla sua fida governante, Céleste Albaret? Dodici, come l’anziana signora ha affermato nelle sue memorie? Di più, di meno? E come non sperare che da qualche cassetto spunti un giorno o l’altro un fascio di manoscritti dimenticati? Dalle soffitte della cognata del romanziere erano ben usciti, negli anni Cinquanta – ad opera di un giovane studioso appassionato, Bernard de Fallois – un intero romanzo inedito, Jean Santeuil, e un saggio critico traboccante di idee originali, il Contro Sainte-Beuve.
Sono proprio i quaderni scomparsi della Recherche – quelli che forse sono stati bruciati, ma magari invece no – a mettere in moto l’intreccio di Delitto in casa Proust. Gisèle Dambert, che sta redigendo una thèse, cioè una tesi di dottorato, sulla genesi della Ricerca, è una ragazza simpatica, timida e sfortunata; eredita da un’anziana signora che le voleva bene un gatto persiano e qualche vecchio mobile. L’affetto del gatto Katiche la consola un po’ dei suoi dispiaceri amorosi: l’affascinante psichiatra libanese che prometteva di lasciare per lei moglie e figli si è rivelato un vero mascalzone. Ma la sorpresa più sconvolgente viene per la giovane studiosa dal doppio fondo di un vecchio secrétaire: data la sua familiarità con i manoscritti di Proust, Gisèle riconosce subito nei quindici quaderni dalla copertina nera che ne vengono fuori una parte consistente e ignorata del manoscritto della Ricerca. L’anziana amica che le ha lasciato in eredità il secrétaire le aveva in effetti raccontato di aver frequentato Céleste Albaret, divenuta, dopo la morte di Proust, custode della casa-museo di Ravel, ma non le aveva mai confidato di essere in possesso di un simile tesoro.
Nella tradizione del romanzo poliziesco, il tesoro è un oggetto ambivalente: suscita bramosie e provoca disastri, promette ricchezza e causa delitti, come il Falcone maltese di Dashiell Hammett, fatto “della materia di cui son fatti i sogni”. I quaderni ritrovati da Gisèle non sono da meno. Rivelano (siamo in una finzione, eh…) che la stesura della Ricerca non è cominciata, come abitualmente si crede, nel 1909, ma nel 1905, e che la figura dell’inafferrabile Albertine non è ispirata soltanto dal bel segretario e autista Alfred Agostinelli, ma da un misterioso giovane aristocratico amato da Marcel Proust molti anni prima. Per la candida Gisèle, quei quaderni sono soltanto una fonte preziosa su cui fondare la thèse, ma nel mondo degli studiosi hanno un immenso valore: garantiscono a chi li pubblicherà fama e successo, onori accademici e visibilità mediatica. La loro scoperta scatena una esacerbata competizione: se li contendono la signora Bertrand-Verdon, ambiziosa fondatrice della Proust Association, il professor Verdaillan, egocentrico accademico francese, e il suo collega americano Patrick L. Rainsford, a caccia di fondi per il suo “Centro dei Manoscritti Postmoderni” (che oggi sarebbe un laboratorio di Digital Humanities: le mode culturali si succedono con implacabile regolarità). Quando tutti gli interessati, compresa Gisèle, che funge da segretaria alla signora Bertrand-Verdon, si ritrovano a Illiers-Combray per il simposio annuale della Proust Association, c’è nell’aria un presagio di tragedia che non tarda a realizzarsi: l’odiosa e prepotente signora Bertrand-Verdon viene assassinata in un ufficio della “Casa della zia Léonie”. Come in un giallo di Agatha Christie, sono molti i personaggi del racconto che avevano ottimi motivi per eliminarla; il commissario Foucheroux e la sua aiutante, l’ispettore Leila Djemani, faticheranno a sbrogliare l’intricata matassa, mentre Gisèle correrà gravi pericoli scongiurati solo all’ultimo momento.
Ci sono veramente tutti gli ingredienti per un poliziesco brillante, originale e anche ricco di humour; l’esattezza dei riferimenti proustiani è garantita dall’identità dell’autrice, la studiosa americana Elyane Dezon-Jones, che si nasconde dietro uno pseudonimo dal suono suggestivo. Possiamo definire impeccabile l’edizione italiana, che ci offre una traduzione aggiornata e scorrevole? Proprio impeccabile, no: a pagina 62 un Dipartimento di Lingue Romanze si trova ribattezzato Dipartimento di Lingue Romaniche, mentre a pagina 161, forse per un simultaneo black out della traduttrice e del proto, la Vue de Delft di Vermeer, citata ne La Prigioniera, si trasforma da Veduta di Delft in Vista di Delfi. Non è un equivoco da poco, certo. Ma credo che Proust si sarebbe molto divertito a veder trasferita in Grecia la “piccola ala di muro giallo” che lo scrittore Bergotte ammira in punto di morte; quella “piccola ala di muro giallo”, simbolo della perfezione artistica, non dovrebbe trovarsi spaesata nella piana di Delfi sacra ad Apollo, Dio della musica e guida delle Muse verso il Monte Parnaso.

